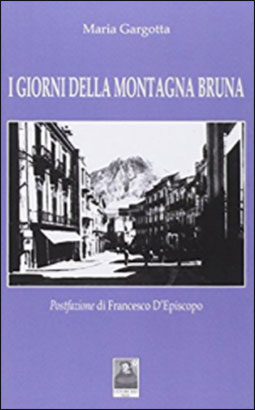 di GIOVANNI URRACI – Le biografie sono normalmente intese come storia della vita di grandi uomini, dei quali si descrivono, ed eventualmente interpretano, ben note e manifeste imprese, gesta e opere. Tuttavia si può fare buona letteratura anche guardando l’esistenza di persone con infelice espressione definite “comuni”, operazione che deve però affrontare una intrinseca difficoltà.
di GIOVANNI URRACI – Le biografie sono normalmente intese come storia della vita di grandi uomini, dei quali si descrivono, ed eventualmente interpretano, ben note e manifeste imprese, gesta e opere. Tuttavia si può fare buona letteratura anche guardando l’esistenza di persone con infelice espressione definite “comuni”, operazione che deve però affrontare una intrinseca difficoltà.
Perché vite semplici possano suscitare interesse e appassionare il lettore è necessario rendere l’unicità di ogni individuo, sempre straordinaria; bisogna mettere a nudo l’anima della persona raccontata e consentire al lettore di entrarvi in contatto esibendone la meravigliosa ricchezza; bisogna descrivere la tumultuosa complessità fatta di pensieri e sentimenti, dubbi e aspirazioni, conflitti e brame che rende ogni uomo eccezionale.
Tutto ciò è possibile solo se è lo scrittore per primo ad avere un rapporto privilegiato con il protagonista: un rapporto come quello che Maria Gargotta possiede con il padre Michele, del quale I giorni della montagna bruna (Postfazione di Francesco D’Episcopo, Città del Sole Edizioni, pp. 238, € 14,00) costituisce un’intima biografia. Si tratta di un’opera che non consiste semplicemente in un affettuoso tributo, quanto piuttosto nel recupero, talvolta tormentato, di un legame la cui forza era sfuggita forse persino ai due interessati, e che ora la penna rivela disegnandone le trame con commovente delicatezza: il testo, infatti, esprime la genuina intenzione della scrittrice di penetrare i più riposti pensieri del genitore così da comprenderne le azioni e le sfumature dietro ai gesti.
Michele nasce negli anni venti a Termini Imerese, città dominata da quel Monte San Calogero implicitamente citato nel titolo stesso del libro, all’ombra del quale sono trascorsi i giorni dell’infanzia, dei giochi, della pasta mai più così buona, delle corse sui ciottoli delle viuzze e del profumo dei dolci di don Buttitta; ma anche delle camurrìe della madre e della sorella, sempre in conflitto, delle premure del fratello e della riservata complicità del padre.
L’infanzia e l’adolescenza sono però soprattutto simbolo di un rapporto naturale e non conflittuale con le proprie radici, radici bruscamente recise quando Michele sceglie di arruolarsi nella Polizia – prima di tante decisioni mai pienamente sue, ma sempre accettate con fatalismo e vissute con impegno: erano gli anni della guerra e quella gli era parsa la migliore alternativa al fronte, perché se proprio si doveva combattere era meglio farlo per costruire l’ordine, «se si doveva sfidare la morte […] almeno si andava a sfidarla per qualcosa di utile» (p. 67).
Ne consegue il trasferimento alle pendici di un’altra montagna, il Vesuvio, e Napoli diventa così la sua nuova casa, ospitale sebbene irrimediabilmente aliena alla sicilianità che scorre nelle vene del protagonista. In Campania maturerà e si dipanerà l’intera sua vita: vi lavorerà, conoscerà la moglie Tina e avrà due figli: una femmina, l’autrice del libro, così distante eppure così simile a lui, e un maschio, tanto desiderato e tanto amato; lì finirà i suoi giorni. Eppure Michele non sarà mai napoletano: lo scirocco continuerà a urlargli nelle orecchie con la voce della madre, a portargli i profumi della cannella e dell’arancia dei dolci tanto amati da bambino, a sussurrargli gli accenti rotondi del suo dialetto col tempo abbandonato. Il suadente richiamo della nostalgia non lo abbandonerà mai, e mai sarà sbiadito dai nuovi affetti: solo quando la Sicilia dei ricordi rivive attraverso le visite del fratello Nino riemergono spontanee le risate e riprendono a fluire le parole, altrimenti sparute; solo allora la sua anima frammentata si ricompone. Maria Gargotta
La malinconia della memoria compone la colonna sonora del libro, e scuote e sorregge l’intera esistenza del suo protagonista: il conflitto tra Michelino, il ragazzino che giocava in via della Verdura, e Michele, poliziotto, marito e padre, è insanabile. Tale lacerazione tra vecchi e nuovi affetti è ben rappresentata dalla sua impossibilità di schierarsi nei non infrequenti scontri tra la madre e la moglie: la prima intona il biasimo della terra che gli diede i natali e che ha poi scelto di abbandonare, la seconda è perfetta incarnazione dell’anima partenopea e quindi della terra che la ospita – ed è proprio “ospite” a descrivere la sua condizione rispetto a quella città.
I giorni della montagna bruna è un racconto intimista, consono al quale è lo stile sobrio ma poetico dell’autrice: l’elegante semplicità delle similitudini e delle immagini offerte al lettore è la stessa dei pensieri di Michele, specchio di un’anima fragile e sensibile costretta a proteggersi dal mondo attraverso uno sguardo calmo che guarda sempre lontano; di un’anima costretta a blindarsi così come fa il corpo indossando il giubbotto antiproiettile: «ora che ci pensava, forse anche per questo aveva scelto di indossare una divisa, per vestire di una corazza la sua sensibile fragilità» (p. 92).
La nostalgia, della quale già si è parlato, non è chiaramente l’unica nota a risuonare in un animo così ricco e profondo, e certamente significative sono le corde fatte vibrare dalle donne della sua vita: Maria Caruso, la madre, alla cui voce severa si rispondeva sempre con l’obbedienza, diventa con il tempo la voce del rimorso che, con una violenta eco, gli ripete «tu mi avi a prumittiri cca, uora, ca torni, cca t’hai a viniri a pigghiari ’a mugghiera» (p. 70-71), evocando così la non mantenuta promessa di fare ritorno a Termini Imerese. Tina, per lui Tatiana, che gli fu maestra quando decise di prendere la licenza media, moglie profondamente gelosa tormentata dall’impossibilità di possedere completamente un marito segnato da un legame con la terra natale dal quale lei era esclusa. Maria Gargotta
Si tratta di figure femminili forti, mai realmente comprese e mai in grado di comprenderlo; ed è proprio questa spaccatura che Maria Gargotta cerca di colmare con il suo romanzo. Nel testo proferisce quelle parole che non ha mai potuto pronunciare, ma soprattutto riscopre l’amore del padre, forte ma forse non sempre consapevole; un amore che, capisce ora, si esprimeva principalmente nella volontà di farle conoscere la Sicilia perché, se fosse riuscita ad apprezzarla, allora avrebbe potuto finalmente comprendere anche lui, avrebbe dunque potuto leggere oltre le sue frasi talvolta impacciate. Michele ci aveva provato anche con la moglie già quando, appena sbocciato l’amore, le portò i dolci della sua terra: «forse quei sapori, quei colori, quei profumi avrebbero dato un po’ di corpo, reso un po’ più chiaro il suo modo di essere, così diverso da quello dei napoletani» (p. 116); non ebbe però successo, Tina mai avrebbe potuto accettare di non essere per il marito tutto il suo mondo.
Un’ultima osservazione va fatta circa Michele: l’aspirazione che guida l’intera sua vita è quella verso la libertà, ricercata da ogni uomo ma che in un’anima involontariamente poetica come la sua acquista un significato speciale. È dalla voglia di libertà che scaturisce ogni cosa, è essa a spingerlo a lasciare la Sicilia nel tentativo di appropriarsi del proprio destino: «attraversare il mare, come tante volte aveva sognato da ragazzo, scoprire cosa c’era al di là, abbattere quell’orizzonte, pure tanto amato; insomma, doveva… assaggiare la libertà» (p. 76). Con la nostalgia imparerà a convivere, essa diventerà parte sofferta del suo carattere, ma l’incitamento alla libertà, seducente sirena, non si placherà mai: la rincorrerà nel canto, passione e piacere che la vecchiaia mina, nei film americani, così lontani dalla realtà, e nei libri, porte su luoghi sognanti nei quali già la madre usava addentrarsi, ma la ricercherà anche nei racconti fantastici da lui stesso immaginati e regalati al figlio. Maria Gargotta
Tutto vano, perché in realtà quella libertà già la possedeva Michelino; l’aveva trovata nella semplicità dei giochi, nelle piccole ribellioni alla severità della madre, l’aveva agguantata nello stringere al petto un pallone sporco di fango e nell’accettare il castigo che macchiare il vestito della festa avrebbe comportato: allora il controllo sulla sua vita, sulle sue azioni e relative conseguenze, era stato totale, e mai lo sarà nuovamente. Michele, dunque, insegue la libertà nel continente; ma Lei rimane in Sicilia ad attenderlo e lo chiama a sé ispirandogli un desiderio insaziabile di ricongiungimento alle proprie origini, gli riporta alla memoria, specialmente nei suoi ultimi giorni, la sfrontata filastrocca che diventa simbolo della spensieratezza dell’infanzia: «Oggi è Duminica / ci tagghiamu a testa a Minica; / Minica nun c’è, / ci tagghiamu a testa o re. / U re è malatu, / ci tagghiamu a testa o suddatu; / u suddatu è a fari a guerra, / ci n’tappamu u culu ’n terra» (p. 5).
Giovanni Urraci Maria Gargotta Maria Gargotta
(www.excursus.org, anno VII, n. 66, gennaio 2015) Maria Gargotta








