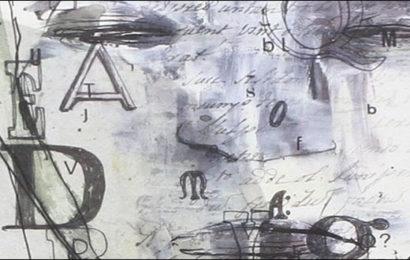di FIORI PICCO – Tira fuori la lingua. Storie dal Tibet dello scrittore cinese Ma Jian (traduzione di Katia Bagnoli, Feltrinelli, pp. 80, € 6,50) è una raccolta di resoconti di viaggio ambientata nel cuore del Continente Asiatico, a cinquemila metri di altitudine, alla scoperta di una civiltà antica, rozza e primitiva.
di FIORI PICCO – Tira fuori la lingua. Storie dal Tibet dello scrittore cinese Ma Jian (traduzione di Katia Bagnoli, Feltrinelli, pp. 80, € 6,50) è una raccolta di resoconti di viaggio ambientata nel cuore del Continente Asiatico, a cinquemila metri di altitudine, alla scoperta di una civiltà antica, rozza e primitiva.
Siamo sull’Altipiano del Tibet, il più vertiginoso e imponente del mondo, terra di fiumi ghiacciati, monasteri lamaisti e laghi salati scintillanti come gemme. Per Ma Jian, protagonista narrante del libro, il viaggio rappresenta una fuga dal passato e dal rapporto tormentato con l’ex-moglie.
A metà degli Anni Ottanta l’autore scappa da Pechino e si avventura verso la Regione Autonoma di Yalasuo, all’epoca il luogo più lontano e isolato per i cinesi, verso una natura mozzafiato, una cultura e una religione differenti, in direzione del Nepal e delle Vette Sacre del Buddhismo. Attraversa sentieri e pascoli desolati, vaga per lande brulle e sconfinate alla ricerca di se stesso e di un contatto umano, con la mente confusa e assillata da visioni surreali di divinità e dai ricordi di un matrimonio fallito.
In Tibet leggenda e realtà si fondono magicamente. Sulle cime più alte e inaccessibili gli indigeni hanno posto la dimora degli dei. È credenza che in ogni valico e dirupo viva uno spirito protettore, dinnanzi al quale la gente recita lunghi e ripetitivi mantra oppure affida le sue orazioni, scritte su sciarpe di seta colorate, volgendo lo sguardo alle montagne, agli stupa disseminati nelle valli e contenenti le reliquie dei Lama, o muovendo i cilindri d’ottone chiamati mulini delle preghiere, che vengono girati a mano dai fedeli centinaia di volte fino alla completa purificazione dello spirito.
Armato di macchina fotografica e sacco a pelo, l’autore dorme sotto il cielo stellato o chiedendo ospitalità ai pochi nomadi dediti alla pastorizia che vivono in tende distanti tra loro decine di chilometri, che odorano di sterco bruciato e carne di montone arrostita. Il paesaggio, di una bellezza ipnotica e sconvolgente, trasmette una sensazione d’inquietudine. Sul Tetto del Mondo il limite fra terreno e soprannaturale, passeggero ed eterno, materiale e trascendente è così sottile che l’uomo si sente minuscolo, impotente e sopraffatto. Anche l’autore, oppresso dall’aria rarefatta e dalla cappa del cielo limpido e turchese come le pietre delle collane che portano le montanare, entra in uno stato di confusione e di trance, non riuscendo più a discernere la realtà dalla fantasia, proseguendo il suo cammino e arrancando come un’inutile e «vuota carcassa».
Se, da un lato, si nota una grande spiritualità nei pellegrini devoti, che si prostrano davanti ai cancelli dei templi o che compiono nove giri intorno al Monte Kailash per purificare la propria anima dai peccati e sperare in un’ascensione al Cielo dopo la morte, dall’altro emergono situazioni umane sconcertanti, al limite della sopportazione e della comprensione. Gli indigeni hanno un atavico spirito di adattamento a condizioni ambientali ostili, a uno stile di vita durissimo, alla miseria, alla sporcizia e ai disagi. Quando l’uomo vive schiacciato da una situazione di estrema povertà, isolato da tutto e dai suoi simili, per disperazione, solitudine e ignoranza, può trasformarsi in una bestia, cedendo agli istinti più bassi e diventando un bruto. È così che nascono violenza e incesto.
Riportando frammenti scabrosi di vite drammatiche, Ma Jian usa uno stile letterario corposo, descrittivo, veristico e incisivo. Leggendo le sue storie ci si sente immediatamente trasportati in Tibet, tra le carovane di mercanti di yak o le danze frenetiche e cadenzate di stregoni camuffati con terribili maschere. Le sue descrizioni delle giovani donne tibetane, pastorelle con le guance rosse e il sorriso puro come l’aria delle praterie, formose, sensuali, appetitose come lamponi selvatici, con la pelle che emana un buon odore di latte caldo, sono incredibilmente vivide e reali. Molto cruda è la narrazione degli aspetti cruenti e macabri della tradizione sciamanica tibetana, come il Rituale della Sepoltura Celeste, durante il quale il maestro spirituale spolpa la carne del defunto, la taglia a pezzetti, tritura le ossa, ne fa una poltiglia con acqua e farina d’orzo e offre il tutto in pasto a falchi, corvi e avvoltoi.
Nelle tende realizzate con pelli di pecora, nei tuguri scuri, freddi e umidi, costruiti con mattoni di fango e sterpi di paglia essiccati al sole, e nelle case di fortuna che si aggrappano ai declini impervi, il cinese di etnia Han annota sul quaderno testimonianze orribili di gente comune, storie di emarginati e di diseredati, che suscitano molta compassione e sgomento. Tra questi personaggi al margine ci sono un padre perseguitato dai sensi di colpa per aver abusato della figlia, nata dal suo rapporto incestuoso con la madre, e Metok, la figlia vagabonda a Lhasa, con i capelli luridi e arruffati come un mazzo di code di yak, che l’autore ha visto al mercato di Barkhor; vive dell’elemosina dei passanti, seminuda, sporca e maleodorante. Per non farsi calpestare dalla gente, si nasconde sotto una bancarella che vende carne ed è circondata da cani randagi.
In Tira fuori la lingua Ma Jian racconta l’animo umano, svelandone le debolezze e le dipendenze psicologiche che, in mancanza di cultura, agiatezza ed educazione morale, si trasformano in malvagi e perversioni, in terribili atrocità. Ci si abbandona all’istinto come selvaggi, per poi rifugiarsi nella preghiera e nella meditazione. Il paesaggio è una triste metafora della caducità e dell’inconsistenza dell’uomo. Quando ci si sofferma a guardare, intorno non si vedono altro che polvere, sassi e sterco puzzolente.
Nell’immaginario occidentale collettivo, i tibetani sono un popolo mite, cordiale e religioso; associamo le parole Shangrila e Catena dell’Himalaya a quelle di Paradiso Terrestre e di Terra Mistica, a luoghi abitati da etnie pacifiche e riflessive, che infondono calma e serenità. Nessuno pensa che la maggior parte di questa gente (donne comprese) porti un lungo pugnale d’argento appeso alla cintura, abbia un’indole focosa e irascibile e mantenga da millenni usi e costumi tribali. Sono essere umani e, come tali, non vanno idealizzati. È questo il messaggio che l’autore trasmette nel libro.
Nella Regione dominano la superstizione e il fatalismo, a vantaggio di stregoni e sciamani. D’altro canto il Lamaismo è anche un miscuglio di pratiche esoteriche e di esercizi tantrici davanti ai quali si rimane stupiti e increduli. Se ci si avvicina con la mente a questo mondo ascetico e incredibilmente spirituale, si scoprirà il manifestarsi di credenze e rituali barbari e assurdi, vere e proprie torture inflitte a poveri innocenti, come le sofferenze e le penitenze imposte a Sangsang Tashi, giovane monaca considerata la reincarnazione di un Buddha Vivente.
Tashi deve sottoporsi a un rito di iniziazione brutale, durante il quale il Buddha della Luce Infinita rimuove dal suo cuore ogni sentimento o desiderio, permettendo alla sua vera natura di riaffiorare e di rivelarsi al mondo. La donna, casta, pia e timorosa, deve unirsi carnalmente al suo maestro durante il Rituale dell’Unione dei Due Corpi, come è riprodotto in un affresco nel quale si vede il dio Vajrapani avvinghiato alla sua sposa. Confusa e terrorizzata all’idea di violare i voti monastici, nel momento in cui, nella grande Sala della Meditazione gremita di monaci, al ritmo frastornante di cembali e con l’odore acre d’incenso e di burro di yak fuso, avviene l’accoppiamento, Tashi si sente improvvisamente vecchia e avvizzita, come se il suo corpo fosse stato martoriato, ridotto a brandelli e prosciugato per sempre. Gli altri Lama, considerati modelli di santità, sono convinti che le sue capacità yogi siano sufficienti a farle superare ogni sofferenza terrena e, di conseguenza, che sia anche in grado di sopravvivere tre giorni all’interno di un fiume ghiacciato.
Ma Jian sottolinea come l’idea di una vita bucolica, idilliaca, a stretto contatto con la natura e con la potenza magnifica e solenne del Divino possa sgretolarsi quando si scontra con il senso di frustrazione nei confronti di una fede cieca e con l’asprezza di un’esistenza fatta di privazioni e di stenti su un altipiano flagellato da tempeste e percorso da venti gelidi. Quando si rende conto della realtà dolorosa e patetica di tanti nomadi trasformati in esseri disumani e spietati, avverte un vuoto profondo nell’animo, si sente inerme e sconfitto. È come un paziente che, tremando, tira fuori la lingua e implora il medico di diagnosticare la malattia. Da questa forte similitudine nasce il titolo di un libro di nicchia, che racchiude cinque storie dai toni feroci, densi e toccanti.
Fiori Picco
(www.excursus.org, anno VII, n. 72, ottobre-novembre 2015)