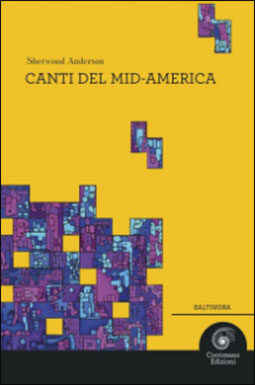 di LEONARDO GATTA – «Il cantore non è né giovane né vecchio ma c’è sempre qualcosa di molto vecchio in lui. L’essenza di molte vite vissute e di molte spese faticosamente fino alla fine scorre piano nella sua voce. Oltre il potere delle parole, le parole si esauriscono. C’è una bellezza spirituale nel canto di colui il cui canto grida dalle anime della gente di tempi e luoghiantichi, ma questa bellezza non ci appartiene ancora». Sherwood Anderson
di LEONARDO GATTA – «Il cantore non è né giovane né vecchio ma c’è sempre qualcosa di molto vecchio in lui. L’essenza di molte vite vissute e di molte spese faticosamente fino alla fine scorre piano nella sua voce. Oltre il potere delle parole, le parole si esauriscono. C’è una bellezza spirituale nel canto di colui il cui canto grida dalle anime della gente di tempi e luoghiantichi, ma questa bellezza non ci appartiene ancora». Sherwood Anderson
“Per questo io voglio cantare”, aggiungeremmo; la formula è di Allen Ginsberg e si dovrebbe posporre a una serie di motivi ronzanti elencati, detti e sottesi a muovere il poeta nel comporre il suo canto. Viceversa, in altre contingenze, la stessa formula anticiperebbe, nella linea del tempo, il contenuto pieno del testo poetico.
Ebbene, ciò che accade in Canti del Mid-America (Corrimano Edizioni, pp. 80, € 10,00) di Sherwood Anderson, è l’itinerario possibile (e possibilmente sinestetico) della formula stessa: “Per questo io voglio cantare”. Posta tra le diverse pieghe del tempo, la reiterazione dei cominciamenti interni all’esistenza, come al cantare, rende la volontà poetica di Anderson una continua invocazione alla palingenesi del mondo occidentale a stelle e strisce (and not only): la voce esprime una preghiera antica, protesa verso gli spazi moderni delle terre industriali. Spazi a loro modo frammentati, machine-lands, «nascondigli oscuri», dove il poeta esiste come «adulto, un uomo-bambino, in America, nell’Occidente, nella grande valle del Mississippi», sulle tracce delle preghiere laiche di Whitman e di Lincoln.
L’ardore di un antico anelito stride al contatto con la coltre fisica della modernità: la luce “mistica dei campi di granoturco” (quel che è Ohio – ripetizione infinita, promessa del granturco, fenomenica ricerca inesausta – preludio al successivo capolavoro Winesburgh, Ohio) incontra necessariamente le porte di Chicago. La città, la carne di tutta la gente, la carne delle mani incontra altre mani differenti; Manhattan si erge in mezzo ad alture sovrastanti la metropoli, in una dialettica continua e sospesa tra le stagioni come tra i diversi pezzi americani. Sherwood Anderson
Di canto in canto, il poeta manifesta “il centro”, come un’eterna allusione all’evocazione partecipata, insita all’esser bravi a disegnare il ritmo sulla carta bianca. Il centro visibile e inafferrabile di questa continua ricerca ossimorica, sicché arcaico-industriale nel medesimo tentativo, è il “Mid-West”, luogo di pensiero torbido, dove il cantore “culla i suoi uomini e produce i suoi canti”, quasi osando cantare (e quasi osa cantando). Ma non vi è mai approdo definitivo; semmai, ciondola l’alternanza allusiva e chiaroscurale insita al ritmo della “matita stretta tra dita scaltre”. Fuori i campi, dentro la città, o viceversa? Dove e quando è datata la perdizione? I medesimi dubbi sulla salvezza.
Gli stessi titoli dei canti mostrano una logica del genere: ad esempio, “il raggio” precede appena il “canto per le notti oscure” (d’altronde Tender is the night: luogo di bisbigli, confessioni e intimo dolore) che, a sua volta, intona la propria ragion d’essere appena prima della renovatio prossima. Gli elementi primari e storici della vita umana vengono cantati nella secolarizzazione americana. Ma il canto è sempre figlio di se stesso, “padre e neonato” del canto e nel canto. Ed è lì che s’esaurisce la serie di interposti tipici di Sherwood Anderson, i bardic moods iridescenti di uno scrittore al settaccio d’America, all’alba inoltrata del Novecento.
Così la palingenesi dell’umanità passa attraverso corde mistiche che scontano le lunghe ore del “giorno che non finisce mai”, o pare non finire nel canto che salva, oscilla e abbaglia portando via con sé le memorie dei campi, il viso rivolto al granturco come si volgesse il pensiero indietro nel tempo. Ed è forte allora il richiamo di quel “c’è qualcosa di molto vecchio in lui”, quasi che il poeta fosse un vecchio-bambino (quel puer-senexpresente e vivo), quasi che la fine fosse l’inizio: rovescio ineludibile all’infinitesimale “Per questo voglio cantare”.
Leonardo Gatta Sherwood Anderson
(www.excursus.org, anno VII, n. 66, gennaio 2015) Sherwood Anderson








